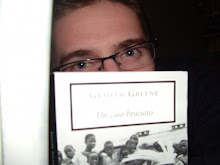Di te, sabbia di aprile,
amo gli attrezzi rumorosi,
i segni di cingoli,
le impronte profonde,
lo sferragliare di chi
rassetta le tue creste e
i tuoi ciottoli levigati
che il mare porta
nel letargo delle altre stagioni.
Di te amo ancora di più
il ritorno
a ciò che è tua essenza:
nuvole di polvere,
risacche,
dune di mille forme lunari.
Chi passa
per questa città
vede soltanto
piastrelle bicolori ordinate in sentieri
e file d'ombrelloni
sotto ai quali,
coppie di sedie a sdraio
formano per istanti,
legami fittizi,
necessità d'ordine
e
non ragione di follia.
Io che vivo tra i tuoi respiri,
conosco il tuo aspetto selvaggio
e quando cammino fra le nebbie
seguendo il richiamo sordo di un faro nascosto,
entro in una stanza segreta dove siamo soli
io e te.
Di te, che non sei sabbia d'aprile,
ma sabbia di clessidra
che segna i miei istanti,
di te,
amo
l'ordine che le persone scorgono
fra le tue movenze,
come a voler richiamare
geometrie anapodittiche -
non sterili formulazioni
ma graziose corrispondenze
di forme e anima -.
Di te, che sei misura della mia anima,
amo ancor di più
il lato che nessuno mai vide
e che ti attraversa come
corsi d'acqua sotterranei,
oscuri e misteriosi,
ignoti all'occhio di chi non possiede quella
luce
che tu doni a chi vuoi:
fiamma che scalda non il curioso passante
che scorge in te bellezza,
piuttosto
fiamma accesa in me,
che ho deciso di vivere
entro i tuoi confini
per farmi straniero a tutto il mondo.
Di te
altro non so che questo:
ciò che non sei agli altri
ciò che sei a me.
E di te
Altro non desidero:
vivere sempre
sul tuo seno profumato,
respirare i tuoi capelli,
camminare con le mie labbra sulle tue labbra,
morire in te e con te
per
rinascere
all’alba del giorno
che è tuo, che è mio.
Non più stanza per due cuori,
o giardino dalle strette pareti,
ma nostro mondo e
nostra espansione.
venerdì 10 aprile 2009
martedì 3 marzo 2009
Canto del viandante visionario
"Ti prego, passeggiamo un poco"
L'aria è pungente
nel soleggiato giorno.
Febbraio è morto da poco
e Marzo, diletto figlio, ne raccoglie
le fredde spoglie.
Camminiamo dunque.
"Ti prego, dammi la mano per un attimo solo,
devo stringerla mentre
provo a dirti chi sono."
Sorrido e mentre dico queste parole,
per me audaci,
distolgo lo sguardo da te.
Toc, toc.
Rumore sordo.
I tacchi delle tue scarpe
rincorrono freneticamente il mio passo
veloce.
Parlo e, ancora,
parlo.
Ti affido frasi d'esiliato,
verbi apolidi.
Le parole che ora pronuncio
sono canti di gitano,
che, pur sempre, sente vivo,
il desiderio di fermarsi in un luogo,
foss' anche
il cielo sotto cui cammina,
o l'arida terra che i suoi piedi calpestano.
"Affido a te la matassa dei miei giorni."
Giro il mio volto per incontrare il tuo viso.
E' silenzio.
Tu,
non sei.
Le voci,
non sono.
Mano che non ho stretto.
Mi guardo intorno.
Cielo cupo
squarciato dalle ultime fiamme del giorno.
Orizzonte impassibile
in cui cerco il conforto
di antichi aneliti di infinito.
Cammino solo.
E con i piedi, nuovamente,
immagino di percorrere la linea lontana,
come un bambino che gioca all'equilibrista,
in bilico ,
tra un infinito e un altro.
L'aria è pungente
nel soleggiato giorno.
Febbraio è morto da poco
e Marzo, diletto figlio, ne raccoglie
le fredde spoglie.
Camminiamo dunque.
"Ti prego, dammi la mano per un attimo solo,
devo stringerla mentre
provo a dirti chi sono."
Sorrido e mentre dico queste parole,
per me audaci,
distolgo lo sguardo da te.
Toc, toc.
Rumore sordo.
I tacchi delle tue scarpe
rincorrono freneticamente il mio passo
veloce.
Parlo e, ancora,
parlo.
Ti affido frasi d'esiliato,
verbi apolidi.
Le parole che ora pronuncio
sono canti di gitano,
che, pur sempre, sente vivo,
il desiderio di fermarsi in un luogo,
foss' anche
il cielo sotto cui cammina,
o l'arida terra che i suoi piedi calpestano.
"Affido a te la matassa dei miei giorni."
Giro il mio volto per incontrare il tuo viso.
E' silenzio.
Tu,
non sei.
Le voci,
non sono.
Mano che non ho stretto.
Mi guardo intorno.
Cielo cupo
squarciato dalle ultime fiamme del giorno.
Orizzonte impassibile
in cui cerco il conforto
di antichi aneliti di infinito.
Cammino solo.
E con i piedi, nuovamente,
immagino di percorrere la linea lontana,
come un bambino che gioca all'equilibrista,
in bilico ,
tra un infinito e un altro.
mercoledì 21 gennaio 2009
Ricordo e Ritratto di un pomeriggio
Per un amico - S.U.
Ricordo e Ritratto di un pomeriggio
Ci conosciamo camminando.
I nostri passi accolti da luoghi familiari
(impronte scricchiolanti sulla sabbia invernale).
Ma come essi,
che sotto i mutevoli cieli - ora tersi ora grigi -
ci lasciano certezza di memoria
e fresche corrispondenze,
così noi,
che siamo gli stessi sempre,
arricchiamo la presenza
con comunione di verbo:
custode dei misteri delle nostre anime,
sacerdote di sogni,
aedo di vite.
Una nave, con sordo rumore,
solca le acque placide,
mentre le barche ormeggiate oscillano
al suono delle arpe eoliche.
I passi ritmati su assi secche di legno.
Ci conosciamo camminando.
Ricordo e Ritratto di un pomeriggio
Ci conosciamo camminando.
I nostri passi accolti da luoghi familiari
(impronte scricchiolanti sulla sabbia invernale).
Ma come essi,
che sotto i mutevoli cieli - ora tersi ora grigi -
ci lasciano certezza di memoria
e fresche corrispondenze,
così noi,
che siamo gli stessi sempre,
arricchiamo la presenza
con comunione di verbo:
custode dei misteri delle nostre anime,
sacerdote di sogni,
aedo di vite.
Una nave, con sordo rumore,
solca le acque placide,
mentre le barche ormeggiate oscillano
al suono delle arpe eoliche.
I passi ritmati su assi secche di legno.
Ci conosciamo camminando.
giovedì 8 gennaio 2009
To D. (my nephew) - in the day of his first birthday
Ti guardo
mentre tu mi guardi:
occhi aperti e attenti
e una smorfia sul tuo volto
che ben presto diventa
largo sorriso.
Ti guardo:
contento dei tuoi versi
di piccola creatura,
stupito.
Sei l'incarnazione di un amore
di cui non sono capace,
un mistero che non riesco
a comprendere:
invidiato in chi lo possiede
senza curarsi della questioni metafisiche,
odiato in me
poichè la sua felicità
fu solo preludio a un lungo dolore.
Ti guardo ancora
mentre scruti attentamente
chi ti circonda:
ogni oggetto e
ogni movimento è
ai tuoi occhi
scoperta e incanto.
Sporge da una sedia
un legaccio di un cuscino,
piccolo nastro di raso grigio:
diviene per te
un nuovo gioco
che vivi intensamente
comunicando la tua gioia
con brevi risate e alcuni
allegri scatti del corpo.
Tutti sorridono.
Io sorrido
e
fissando ancora i tuoi movimenti,
prego:
meraviglia e gioia
siano il tuo passo destro
e il tuo passo sinistro,
speranza il tuo sguardo,
amore il sangue che ostinato scorre nel tuo corpo,
misericordia le tue mani,
grazia la tua bocca;
come vento audace
possa tu erodere la monotonia
del mondo a cui da poco sei nato,
modellando forme nelle dune,
passando tra i rami fermi,
donando sollievo nel giorno afoso.
mentre tu mi guardi:
occhi aperti e attenti
e una smorfia sul tuo volto
che ben presto diventa
largo sorriso.
Ti guardo:
contento dei tuoi versi
di piccola creatura,
stupito.
Sei l'incarnazione di un amore
di cui non sono capace,
un mistero che non riesco
a comprendere:
invidiato in chi lo possiede
senza curarsi della questioni metafisiche,
odiato in me
poichè la sua felicità
fu solo preludio a un lungo dolore.
Ti guardo ancora
mentre scruti attentamente
chi ti circonda:
ogni oggetto e
ogni movimento è
ai tuoi occhi
scoperta e incanto.
Sporge da una sedia
un legaccio di un cuscino,
piccolo nastro di raso grigio:
diviene per te
un nuovo gioco
che vivi intensamente
comunicando la tua gioia
con brevi risate e alcuni
allegri scatti del corpo.
Tutti sorridono.
Io sorrido
e
fissando ancora i tuoi movimenti,
prego:
meraviglia e gioia
siano il tuo passo destro
e il tuo passo sinistro,
speranza il tuo sguardo,
amore il sangue che ostinato scorre nel tuo corpo,
misericordia le tue mani,
grazia la tua bocca;
come vento audace
possa tu erodere la monotonia
del mondo a cui da poco sei nato,
modellando forme nelle dune,
passando tra i rami fermi,
donando sollievo nel giorno afoso.
martedì 23 dicembre 2008
Dopo un silenzio
Una delle mie ultime riflessioni. Sarà mai poesia? Non lo so.
Perchè, dopotutto, vorrei che queste parole non fossero precise e capaci di definire tutto come su un vocabolario, quanto, piuttosto, vorrei fossero come impressioni, macchie di colore, fotografie forse un po' sfuocate che suggeriscono, ma in cui si possa vedere molto di più di quanto il contorno definito possa dire.
Mi rimetto alla clemenza e alla immaginazione di chi leggerà.
J.
"L'odore di matita cancellata"
L'odore di matita cancellata
e il gesto divertito
di soffiar via con decisione
la strana amalgama di grafite e gomme sintetiche,
mi ricorda
dei pomeriggi a scuola,
quando messo nuovamente il grembiule azzuro,
dopo l'intenso giocare a calcio contro un cancello
e le fantasiose impersonificazioni
- "Io sono tal dei tali",
"Facciamo Juve contro Toro",
"No" esclamava un bimbo smaniosamente
che voleva una sfida ancora più esaltante,
"Facciamo Milan contro l'Italia tutta" -,
si tornava alla grigia aula,
passando per i corridoi che,
brulicanti la mattina di visini,
ora assistevano impietriti
alla processione verso i banchi:
verdi,
uniformi,
uguali,
puliti.
Due ore di esercizi di scrittura:
ora le "a"
ora le "b".
Le mie "emme"
avevano sempre
più colonne e più archi del necessario.
Le sapevo scrivere:
ma fin da piccolo
ho sempre creduto
nell'ortografia dell'immaginazione.
Perchè, dopotutto, vorrei che queste parole non fossero precise e capaci di definire tutto come su un vocabolario, quanto, piuttosto, vorrei fossero come impressioni, macchie di colore, fotografie forse un po' sfuocate che suggeriscono, ma in cui si possa vedere molto di più di quanto il contorno definito possa dire.
Mi rimetto alla clemenza e alla immaginazione di chi leggerà.
J.
"L'odore di matita cancellata"
L'odore di matita cancellata
e il gesto divertito
di soffiar via con decisione
la strana amalgama di grafite e gomme sintetiche,
mi ricorda
dei pomeriggi a scuola,
quando messo nuovamente il grembiule azzuro,
dopo l'intenso giocare a calcio contro un cancello
e le fantasiose impersonificazioni
- "Io sono tal dei tali",
"Facciamo Juve contro Toro",
"No" esclamava un bimbo smaniosamente
che voleva una sfida ancora più esaltante,
"Facciamo Milan contro l'Italia tutta" -,
si tornava alla grigia aula,
passando per i corridoi che,
brulicanti la mattina di visini,
ora assistevano impietriti
alla processione verso i banchi:
verdi,
uniformi,
uguali,
puliti.
Due ore di esercizi di scrittura:
ora le "a"
ora le "b".
Le mie "emme"
avevano sempre
più colonne e più archi del necessario.
Le sapevo scrivere:
ma fin da piccolo
ho sempre creduto
nell'ortografia dell'immaginazione.
lunedì 17 novembre 2008
Sfoghi
Semplicemente nero su bianco. Dai miei taccuini: due "non-so-nemmeno-come-chiamarle". Diario di un cuore in movimento. Rappresentazioni di un'anima inquieta CREATA per la pace. E come Hopkins mi domando: "When will you ever, Peace, wild wooddove, shy wings shut, your round me roaming end, and under be my boughs?"
Regards and blessings
J.
HO COMINCIATO UN NUOVO TACCUINO
"Ho cominciato un nuovo taccuino
ma non una nuova pagina della mia vita:
scrivo ancora di lotte non risolte.
La ferita non recede nè si satura
ma, infetta e imputridita,
si sazia di pezzi di me,
lentamente.
La carne necrotica non dà più
sensazione di dolore;
l'anima al contrario
amplifica l'agonia risuonando.
Talvolta lo spasmo si assopisce
e un abbozzo di sorriso sembra sottolineare
la speranza di una guarigione.
Talvolta, improvvisamente, mi guardo
allo specchio e vedo
l'uomo interiore deformato,
mentre i miei occhi fissano
i segni della crescita del corpo e
del suo invecchiamento.
Curo assiduamente l'esterno della coppa
eppure sento l'aceto al suo interno.
Una volta credo fosse vino buono.
IO SONO CHARLIE BROWN - una riflessione
La cassetta delle lettere
era vuota oggi.
Non v'erano neppure
i tediosi pamphlet
dai convenientissimi affari.
Vero Charlie Brown
ho scosso il mio ciuffo di capelli.
Chino la mia testa,
Malinconico,
nel guantone di pelle.
Sarà per un'altra volta
ragazza dai capelli rossi.
Regards and blessings
J.
HO COMINCIATO UN NUOVO TACCUINO
"Ho cominciato un nuovo taccuino
ma non una nuova pagina della mia vita:
scrivo ancora di lotte non risolte.
La ferita non recede nè si satura
ma, infetta e imputridita,
si sazia di pezzi di me,
lentamente.
La carne necrotica non dà più
sensazione di dolore;
l'anima al contrario
amplifica l'agonia risuonando.
Talvolta lo spasmo si assopisce
e un abbozzo di sorriso sembra sottolineare
la speranza di una guarigione.
Talvolta, improvvisamente, mi guardo
allo specchio e vedo
l'uomo interiore deformato,
mentre i miei occhi fissano
i segni della crescita del corpo e
del suo invecchiamento.
Curo assiduamente l'esterno della coppa
eppure sento l'aceto al suo interno.
Una volta credo fosse vino buono.
IO SONO CHARLIE BROWN - una riflessione
La cassetta delle lettere
era vuota oggi.
Non v'erano neppure
i tediosi pamphlet
dai convenientissimi affari.
Vero Charlie Brown
ho scosso il mio ciuffo di capelli.
Chino la mia testa,
Malinconico,
nel guantone di pelle.
Sarà per un'altra volta
ragazza dai capelli rossi.
venerdì 7 novembre 2008
Le Braccia e le Mani di Dio - Come antropomorfismi, metafore e immagini ci invitano ulteriormente alla comunione con il Dio Trino
Lettura
Gal. 4:4-6, Deut. 33:27, Ebr. 2:10-14
“La poesia non è il linguaggio della spiegazione oggettiva ma il linguaggio dell’immaginazione. Essa fornisce un’immagine della realtà in modo tale da invitarci a partecipare in essa. Non abbiamo più informazioni dopo aver letto una poesia; abbiamo più esperienza. Non è un “esame di quello che accade ma un’immersione in ciò che accade” (E. Peterson – Reversed Thunder)
Braccia.
Braccia muscolose e allenate, braccia esili e intellettuali, braccia glabre e braccia pelose, braccia su cui la camicia è arrotolata e braccia su cui la camicia è ben abbottonata, braccia abbronzate e braccia bianche come il latte, braccia di adulto e braccia di bambino, braccia ferite e braccia dalla pelle liscia, braccia sudate e braccia profumate, braccia su cui il duro lavoro lascia segni e braccia su cui l’unico segno è l’impronta della scrivania, braccia di adulto, protettive, braccia di bambino, in cerca di protezione, braccia che stringiamo intorno a chi amiamo, braccia che ci stringono per dire che siamo amati,braccia capaci di alzare pesi e braccia capaci di cullare, braccia di uomo e braccia di donna, braccia umane e braccia di Dio.
Braccia di Dio.
Eterne, forti e potenti eppure anche tenere e delicate, “spirituali” e “materiali”, talvolta come nascoste e talvolta come tangibili, eppure braccia sempre presenti perché ciò che l’occhio non vede il cuore sa; braccia che reggono gli universi e i mondi e braccia che accolgono un figlio prodigo al suo ritorno; braccia che erano presenti prima ancora che il mondo fosse in un tempo chiamato eternità, braccia che si stendono verso un tempo futuro chiamato eternità, braccia del Dio degli eserciti e braccia del Dio Pastore, dunque braccia di Dio con tutte le sfumature e i colori che questa immagine ha.
Mosè conosceva quelle braccia. Le aveva viste operare nella sua vita e nella vita del popolo di Israele. Braccia che non si conoscono come in un manuale di anatomia, studiandole e definendo i muscoli e i nervi: così sono braccia asettiche, intellettualizzate, ma ferme come quelle di un manichino; piuttosto braccia che si conoscono per esperienza e contatto con esse, braccia che si vogliono definire per noi e rivelarsi, braccia che seguono l’impulso di un sentimento eterno di comunione, dimora, braccia mosse dal cuore di Dio.
Ecco perché nel suo canto del cigno il profeta con cui Dio trattava faccia a faccia come con un amico intimo, in un impeto immaginifico e ispirato, guarda con gli occhi lucidi al popolo e scorge qualcosa che soltanto gli occhi di un profeta possono vedere. Dietro ai volti delle persone, a quella folla di uomini, donne e bambini, c’era molto di più di Israele stesso, molto più di vesti sgargianti, di tende, di cibo, di scudi, di barbe e copricapo, di monili e profumi. Dietro a tutto questo c’era Dio stesso:
“Il Dio eterno è il tuo rifugio
E sotto di te stanno le braccia eterne”
(Deuteronomio 33:27)
Mani.
Mani bianche e mani scure, mani gialle e mani nere, ma la cui vita proviene da uno stesso sangue rosso, mani callose e mani curate, mani piagate e mani morbide, mani forti e mani esili, mani che disegnano e mani che costruiscono, mani che schiaffeggiano e mani che accarezzano, mani grandi e mani piccole, mani che si stringono e mani che si separano, mani che benedicono e mani che insultano, mani che sferruzzano e mani che scrivono, mani che eseguono movimenti coordinati su tasti ora bianchi ora neri e mani che hanno scolpito quegli stessi tasti, mani nude e mani ornate da anelli, mano destra e mano sinistra, mani che si alzano e mani che stanno ferme, mani di uomini e mani di Dio.
Mani di Dio.
Eterne, le cui dita hanno disposto negli spazi siderei le stelle e gli astri e le cui dita hanno toccato cuori di pietra, mani pure eppure che non hanno paura di sporcarsi toccando lebbrosi, malati, peccatori, uomini e donne, me e te, mani senza guanti, mani che sostengono, mani che agiscono, mani che proteggono, mani che stringono a sé, mani che custodiscono, mani che donano, mani che hanno aperto una via per cui camminare e mani che indicano il sentiero da percorrere, mani che hanno scritto la storia e mani che creano una nuova storia nella vita di ogni essere umano, mani fedeli e piene di promesse, mani sui cui palmi sono scolpiti i ritratti di persone come perenne ricordo d’amore, mani sui cui palmi, fra visi e volti, c’è il segno di chiodi, mani che reggono l’universo eppure mani ferite, mani di Dio con tutto quello che quest’ulteriore immagine comunica in tutta la sua grandeur.
Mosè conosceva quelle mani. Quando sul monte Dio fece passare davanti a Mosè tutta la Sua bontà proclamando la Sua gloria (Esodo 33:19), la mano di Dio coprì il decano dei profeti; messo in una buca di un masso, Mosè sentì su di sé la mano di Dio.
Quelle stesse mani che avevano operato prodigi; quelle stesse mani che con un dito scrissero su tavole di pietra e quelle stesse mani che scrivono oggi su tavole di carne chiamate cuori. Mani sempre tese verso l’uomo, mani che si sono fatte toccare dalle nostre mani (cfr. 1 Giov. 1:1-4), mani che, come Giovanni ci dice nella visione grandiosa che contemplò, asciugheranno le nostre lacrime; mani che come spezzarono del pane sulla via per Emmaus per due discepoli lo spezzeranno ancora per molti altri quando saremo a tavola con Lui.
Antropomorfismi.
Questo il nome tecnico che gli studiosi danno a immagini come queste: Dio con braccia, con piedi, con mani, con viscere e cuore. Spesso trascurate o prese soltanto come metafore esse sono invece l’anticamera al più grande “antropomorfismo” a cui si assiste nella rivelazione biblica: l’incarnazione. Non metafora, ma Cristo perfetto Dio e perfetto uomo.
Questo modo che Dio ha di parlare alle Sue creature ha origine nel Suo desiderio di comunicare e rivelarsi non in maniera distaccata e asettica, come se i Suoi attributi potessero essere oggetto di critica e analisi metodologica, ma soprattutto in maniera personale e intima. Non solo. Questo modo di parlare ha origine in quel desiderio tipico del “Circolo Trinitario” di chiamare all’interno della “comunità del Dio Trino” l’uomo. Dio ci vuole includere in quel dialogo e in quella relazione che sussiste da ogni tempo tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Le Sue braccia e le Sue mani sono protese verso di noi annunciando questo invito.
E siccome la teologia è lo studio di Dio, del Suo carattere e delle Sue vie, non sorprende che nel corso del tempo qualcuno cogliesse con grande efficacia queste immagini di braccia e mani, non solo facendolo proprie nel cuore ma anche facendocele riscoprire con voce al contempo biblica, profetica e poetica. La teologia diventa così una ricerca all’interno della rivelazione (“cerchiamo come chi sta per trovare, troviamo come chi sta per cercare” diceva Agostino), riscoprendola di volta in volta nella sua purezza originale, purezza che spesso rischiamo di perdere perché presi piuttosto dalle nostre agende, dalle nostre preoccupazioni, dai nostri piani. Questa volta la voce che si alza è quella di un apologeta, cioè di un teologo che dedicò la sua vita alla difesa della fede Cristiana. Ireneo di Lione usa una metafora straordinaria che preserva la ricchezza della metafora biblica stessa. Dio è intervenuto nella storia umana attraverso due mani, cioè attraverso la Parola e lo Spirito, attraverso Cristo (la Parola incarnata) e lo Spirito.
Il Nuovo Testamento concordemente ci spiega in modo estensivo questa metafora che affonda le sue radici nell’Antico Testamento e che Ireneo colse nuovamente qualche anno più tardi nella sua difesa della fede dagli attacchi di Marcione e dello gnosticismo.
Al fine di condurre molti figli alla gloria, l’autore anonimo dell'epistola agli Ebrei, ci dice che “poiché i figli hanno in comune sangue e carne, Egli [Cristo cioè] pure vi ha similmente partecipato”(Ebrei 2:10, 14). Paolo stesso fa eco a questa melodia dicendo che “quando giunse la pienezza del tempo Dio mandò Suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinchè noi ricevessimo l’adozione” (Galati 4:4-5).
La “prima mano”: Cristo incarnato. Egli che prende su di sé la natura umana e compie l’opera di redenzione per l’uomo.
Paolo stesso ci ricorda poi che “avete ricevuto lo Spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abbà, Padre” (Romani 8:15). Affermazione di cui troviamo ulteriore conferma nuovamente in Galati dove l’apostolo scrive che “perché siete figli Dio ha mandato lo Spirito del Figlio Suo nei nostri cuori, che grida Abbà, Padre” (Galati 4:6).
La “seconda mano”: lo Spirito Santo nei nostri cuori, Colui che produce in noi la vita di Cristo e agisce in noi per trasformarci, sigillandoci come proprietà speciale di Dio.
“In Cristo, la Parola fatta carne, e nello Spirito, siamo condotti al Padre attraverso l’intercessione di Cristo e l’intercessione dello Spirito. Siamo sollevati dalle “braccia eterne”” (James B. Torrance, Community, Worship and the Triune God of Grace, IVP) .
Le immagini di mani e braccia di Dio hanno così la loro massima espressione non primariamente sul piano metaforico (per quanto grandiose e profonde siano queste immagini), ma su un piano reale e tangibile. Le braccia di Dio e le Sue mani non sono solo antropomorfismi da gettare in pasto ai critici letterari e agli esegeti, ma sono il modo che Dio ha di attirarci a sé e di arrivare a noi.
Guardando la vita ci è offerta la possibilità di andare con lo sguardo oltre all’immediato e scorgere dietro a vestiti, sguardi, volti, barbe, capelli lunghi, libri e tomi, programmi di studio, progetti, numeri di telefono ed elenchi, la stessa cosa che Mosè vide, che Paolo esponeva con tanto pathos, che il misterioso autore della lettera agli Ebrei scrisse ad amici in difficoltà e che Ireneo, decine d’anni espose nuovamente nella sua poetica apologia: dietro a noi stanno le braccia e le mani di Dio.
Eterne.
Forti.
Piene di grazia.
Cristo e lo Spirito.
Dio con noi. Dio per noi. Dio in noi.
Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo.
Vivere sempre tra le Sue braccia, seduti nell’incavo delle Sue mani, vicino al Suo cuore, sotto il Suo sguardo, all’ombra del Suo sorriso.
Gal. 4:4-6, Deut. 33:27, Ebr. 2:10-14
“La poesia non è il linguaggio della spiegazione oggettiva ma il linguaggio dell’immaginazione. Essa fornisce un’immagine della realtà in modo tale da invitarci a partecipare in essa. Non abbiamo più informazioni dopo aver letto una poesia; abbiamo più esperienza. Non è un “esame di quello che accade ma un’immersione in ciò che accade” (E. Peterson – Reversed Thunder)
Braccia.
Braccia muscolose e allenate, braccia esili e intellettuali, braccia glabre e braccia pelose, braccia su cui la camicia è arrotolata e braccia su cui la camicia è ben abbottonata, braccia abbronzate e braccia bianche come il latte, braccia di adulto e braccia di bambino, braccia ferite e braccia dalla pelle liscia, braccia sudate e braccia profumate, braccia su cui il duro lavoro lascia segni e braccia su cui l’unico segno è l’impronta della scrivania, braccia di adulto, protettive, braccia di bambino, in cerca di protezione, braccia che stringiamo intorno a chi amiamo, braccia che ci stringono per dire che siamo amati,braccia capaci di alzare pesi e braccia capaci di cullare, braccia di uomo e braccia di donna, braccia umane e braccia di Dio.
Braccia di Dio.
Eterne, forti e potenti eppure anche tenere e delicate, “spirituali” e “materiali”, talvolta come nascoste e talvolta come tangibili, eppure braccia sempre presenti perché ciò che l’occhio non vede il cuore sa; braccia che reggono gli universi e i mondi e braccia che accolgono un figlio prodigo al suo ritorno; braccia che erano presenti prima ancora che il mondo fosse in un tempo chiamato eternità, braccia che si stendono verso un tempo futuro chiamato eternità, braccia del Dio degli eserciti e braccia del Dio Pastore, dunque braccia di Dio con tutte le sfumature e i colori che questa immagine ha.
Mosè conosceva quelle braccia. Le aveva viste operare nella sua vita e nella vita del popolo di Israele. Braccia che non si conoscono come in un manuale di anatomia, studiandole e definendo i muscoli e i nervi: così sono braccia asettiche, intellettualizzate, ma ferme come quelle di un manichino; piuttosto braccia che si conoscono per esperienza e contatto con esse, braccia che si vogliono definire per noi e rivelarsi, braccia che seguono l’impulso di un sentimento eterno di comunione, dimora, braccia mosse dal cuore di Dio.
Ecco perché nel suo canto del cigno il profeta con cui Dio trattava faccia a faccia come con un amico intimo, in un impeto immaginifico e ispirato, guarda con gli occhi lucidi al popolo e scorge qualcosa che soltanto gli occhi di un profeta possono vedere. Dietro ai volti delle persone, a quella folla di uomini, donne e bambini, c’era molto di più di Israele stesso, molto più di vesti sgargianti, di tende, di cibo, di scudi, di barbe e copricapo, di monili e profumi. Dietro a tutto questo c’era Dio stesso:
“Il Dio eterno è il tuo rifugio
E sotto di te stanno le braccia eterne”
(Deuteronomio 33:27)
Mani.
Mani bianche e mani scure, mani gialle e mani nere, ma la cui vita proviene da uno stesso sangue rosso, mani callose e mani curate, mani piagate e mani morbide, mani forti e mani esili, mani che disegnano e mani che costruiscono, mani che schiaffeggiano e mani che accarezzano, mani grandi e mani piccole, mani che si stringono e mani che si separano, mani che benedicono e mani che insultano, mani che sferruzzano e mani che scrivono, mani che eseguono movimenti coordinati su tasti ora bianchi ora neri e mani che hanno scolpito quegli stessi tasti, mani nude e mani ornate da anelli, mano destra e mano sinistra, mani che si alzano e mani che stanno ferme, mani di uomini e mani di Dio.
Mani di Dio.
Eterne, le cui dita hanno disposto negli spazi siderei le stelle e gli astri e le cui dita hanno toccato cuori di pietra, mani pure eppure che non hanno paura di sporcarsi toccando lebbrosi, malati, peccatori, uomini e donne, me e te, mani senza guanti, mani che sostengono, mani che agiscono, mani che proteggono, mani che stringono a sé, mani che custodiscono, mani che donano, mani che hanno aperto una via per cui camminare e mani che indicano il sentiero da percorrere, mani che hanno scritto la storia e mani che creano una nuova storia nella vita di ogni essere umano, mani fedeli e piene di promesse, mani sui cui palmi sono scolpiti i ritratti di persone come perenne ricordo d’amore, mani sui cui palmi, fra visi e volti, c’è il segno di chiodi, mani che reggono l’universo eppure mani ferite, mani di Dio con tutto quello che quest’ulteriore immagine comunica in tutta la sua grandeur.
Mosè conosceva quelle mani. Quando sul monte Dio fece passare davanti a Mosè tutta la Sua bontà proclamando la Sua gloria (Esodo 33:19), la mano di Dio coprì il decano dei profeti; messo in una buca di un masso, Mosè sentì su di sé la mano di Dio.
Quelle stesse mani che avevano operato prodigi; quelle stesse mani che con un dito scrissero su tavole di pietra e quelle stesse mani che scrivono oggi su tavole di carne chiamate cuori. Mani sempre tese verso l’uomo, mani che si sono fatte toccare dalle nostre mani (cfr. 1 Giov. 1:1-4), mani che, come Giovanni ci dice nella visione grandiosa che contemplò, asciugheranno le nostre lacrime; mani che come spezzarono del pane sulla via per Emmaus per due discepoli lo spezzeranno ancora per molti altri quando saremo a tavola con Lui.
Antropomorfismi.
Questo il nome tecnico che gli studiosi danno a immagini come queste: Dio con braccia, con piedi, con mani, con viscere e cuore. Spesso trascurate o prese soltanto come metafore esse sono invece l’anticamera al più grande “antropomorfismo” a cui si assiste nella rivelazione biblica: l’incarnazione. Non metafora, ma Cristo perfetto Dio e perfetto uomo.
Questo modo che Dio ha di parlare alle Sue creature ha origine nel Suo desiderio di comunicare e rivelarsi non in maniera distaccata e asettica, come se i Suoi attributi potessero essere oggetto di critica e analisi metodologica, ma soprattutto in maniera personale e intima. Non solo. Questo modo di parlare ha origine in quel desiderio tipico del “Circolo Trinitario” di chiamare all’interno della “comunità del Dio Trino” l’uomo. Dio ci vuole includere in quel dialogo e in quella relazione che sussiste da ogni tempo tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Le Sue braccia e le Sue mani sono protese verso di noi annunciando questo invito.
E siccome la teologia è lo studio di Dio, del Suo carattere e delle Sue vie, non sorprende che nel corso del tempo qualcuno cogliesse con grande efficacia queste immagini di braccia e mani, non solo facendolo proprie nel cuore ma anche facendocele riscoprire con voce al contempo biblica, profetica e poetica. La teologia diventa così una ricerca all’interno della rivelazione (“cerchiamo come chi sta per trovare, troviamo come chi sta per cercare” diceva Agostino), riscoprendola di volta in volta nella sua purezza originale, purezza che spesso rischiamo di perdere perché presi piuttosto dalle nostre agende, dalle nostre preoccupazioni, dai nostri piani. Questa volta la voce che si alza è quella di un apologeta, cioè di un teologo che dedicò la sua vita alla difesa della fede Cristiana. Ireneo di Lione usa una metafora straordinaria che preserva la ricchezza della metafora biblica stessa. Dio è intervenuto nella storia umana attraverso due mani, cioè attraverso la Parola e lo Spirito, attraverso Cristo (la Parola incarnata) e lo Spirito.
Il Nuovo Testamento concordemente ci spiega in modo estensivo questa metafora che affonda le sue radici nell’Antico Testamento e che Ireneo colse nuovamente qualche anno più tardi nella sua difesa della fede dagli attacchi di Marcione e dello gnosticismo.
Al fine di condurre molti figli alla gloria, l’autore anonimo dell'epistola agli Ebrei, ci dice che “poiché i figli hanno in comune sangue e carne, Egli [Cristo cioè] pure vi ha similmente partecipato”(Ebrei 2:10, 14). Paolo stesso fa eco a questa melodia dicendo che “quando giunse la pienezza del tempo Dio mandò Suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinchè noi ricevessimo l’adozione” (Galati 4:4-5).
La “prima mano”: Cristo incarnato. Egli che prende su di sé la natura umana e compie l’opera di redenzione per l’uomo.
Paolo stesso ci ricorda poi che “avete ricevuto lo Spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abbà, Padre” (Romani 8:15). Affermazione di cui troviamo ulteriore conferma nuovamente in Galati dove l’apostolo scrive che “perché siete figli Dio ha mandato lo Spirito del Figlio Suo nei nostri cuori, che grida Abbà, Padre” (Galati 4:6).
La “seconda mano”: lo Spirito Santo nei nostri cuori, Colui che produce in noi la vita di Cristo e agisce in noi per trasformarci, sigillandoci come proprietà speciale di Dio.
“In Cristo, la Parola fatta carne, e nello Spirito, siamo condotti al Padre attraverso l’intercessione di Cristo e l’intercessione dello Spirito. Siamo sollevati dalle “braccia eterne”” (James B. Torrance, Community, Worship and the Triune God of Grace, IVP) .
Le immagini di mani e braccia di Dio hanno così la loro massima espressione non primariamente sul piano metaforico (per quanto grandiose e profonde siano queste immagini), ma su un piano reale e tangibile. Le braccia di Dio e le Sue mani non sono solo antropomorfismi da gettare in pasto ai critici letterari e agli esegeti, ma sono il modo che Dio ha di attirarci a sé e di arrivare a noi.
Guardando la vita ci è offerta la possibilità di andare con lo sguardo oltre all’immediato e scorgere dietro a vestiti, sguardi, volti, barbe, capelli lunghi, libri e tomi, programmi di studio, progetti, numeri di telefono ed elenchi, la stessa cosa che Mosè vide, che Paolo esponeva con tanto pathos, che il misterioso autore della lettera agli Ebrei scrisse ad amici in difficoltà e che Ireneo, decine d’anni espose nuovamente nella sua poetica apologia: dietro a noi stanno le braccia e le mani di Dio.
Eterne.
Forti.
Piene di grazia.
Cristo e lo Spirito.
Dio con noi. Dio per noi. Dio in noi.
Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo.
Vivere sempre tra le Sue braccia, seduti nell’incavo delle Sue mani, vicino al Suo cuore, sotto il Suo sguardo, all’ombra del Suo sorriso.
sabato 1 novembre 2008
Possa la Sua polvere avvolgerti
Alcune riflessioni di un giovedì sera di qualche settimana fa.
Blessings.
J.
Luca 5:27-32
“ […] un monumento dice soltanto “sono arrivato fin qua” mentre un’orma dice “ero qui quando sono ripartito” (W. Faulkner)
Levi sedeva al banco delle imposte come ogni giorno, esercitando la sua impopolare professione. Egli era un impiegato dell’ufficio delle imposte e dunque una persona la cui figura ricordava costantemente ai suoi connazionali come Israele fosse una nazione soggetta, politicamente, all’impero Romano. Non solo. Levi era una di quelle persone che la gente cercava con tutte le forze di evitare: il Talmud stesso definiva gli esattori di tasse, forse con qualche ragione, dei “rapinatori”.
Gesù era appena uscito dalla casa in cui aveva guarito un uomo paralitico e stava, probabilmente, uscendo dalla città quando incontrò Levi. Lo trovò mentre egli stava esercitando le sue contestate mansioni.
Gesù lo notò. Lo guardò e gli rivolse una semplice parola: “Seguimi”.
La risposta di Levi fu sorprendentemente rapida. Egli lasciata ogni cosa (un particolare che Luca sottolinea con gran vigore rispetto agli altri sinottici), si alzò in piedi e si mise a seguirlo.
Si mise a seguirlo.
Questa espressione così concisa è molto densa e ricca di implicazioni. Per Levi, significò perdere in maniera definitiva il proprio posto di lavoro. Una volta abbandonata quella postazione egli non poteva più tornare indietro: quel gesto era un biglietto di sola andata, un’azione definitiva. Egli lasciò dietro alle spalle le sue ricchezze. Solitamente infatti, gli esattori di tasse, per non parlare poi dei capi di distretto come Zaccheo, erano persone benestanti con un letto soffice sotto il quale stavano tante tintinnanti monete. Alzarsi e seguire Gesù implicava la rinuncia a tutto questo, che da qualche anno era stato il mondo del puntuale esattore di tasse.
Ciò che però colpisce ancora più con vigore in questo brano è il verbo che Luca usa per esprimere ciò che fece Levi. Si mise a seguirlo, cioè Levi cominciò quel giorno a seguire Gesù. Akolutheo è un verbo molto bello, usato primariamente nei Vangeli: riferito alle folle è usato in senso neutrale e non implica il formarsi di qualche convinzione. È forse il seguire delle folle e delle masse, fatto più di curiosità che di passione personale. Quando però è riferito a singoli individui esso prende il significato di “seguire in rapporto intimo”; esso sottolinea l’inizio di quel “cammino lungo e in una sola direzione” che è noto come l’essere discepoli.
Levi aveva appena mosso il primo passo su quella strada che può essere percorsa soltanto in avanti.
L’immagine che questo verbo e questa azione suggeriscono è di straordinaria potenza perché si inserisce nel contesto dell’epoca con una dimensione nuova e fresca. Nella cultura di quei tempi era pratica comune scegliere un rabbi che diventasse la propria guida. Scelto il rabbi, il discepolo aveva una sola occupazione: ricevere più nozioni e insegnamenti possibili dal proprio maestro. Questo aspetto era così sentito che il maestro era seguito dovunque: mentre camminava, mentre parlava con altri, mentre comprava la frutta e la verdura, mentre svolgeva le faccende domestiche e addirittura mentre andava in bagno! La paura era quella di perdere una eventuale “perla” di saggezza o di non imparare una nuova preghiera. Si narra nel Talmud di una caso estremo in cui un discepolo scivolò di soppiatto nel letto del proprio rabbi e si pose tra moglie e marito, sotto le coperte. Al rimprovero del maestro egli rispose “Anche questa è Torah e devo imparare”. A parte i casi estremi, si comprende l’importanza di questo atto di seguire il proprio rabbi da una benedizione che uno studioso di Antico Testamento, Ray van der Laan, ci riporta:
“possa tu esser sempre ricoperto dalla polvere del tuo maestro”.
Possa cioè la polvere dei piedi del tuo maestro, alzata dai suoi sandali, coprire le tue vesti e avvolgerti, perché ciò significa che lo stai seguendo mentre lui cammina, significa che i tuoi occhi sono puntati su di lui, che le tue orecchie sono protese e pronte ad ascoltare ogni sua parola.
Levi cominciò questo tipo di cammino.
Fu Gesù, il Maestro, che cercò Levi. Gesù affermò di esser venuto specificatamente e volontariamente a chiamare l’esattore di tasse. Infatti, ai farisei che come al solito erano scioccati e scandalizzati dal fatto che il Signore si associasse con gli emarginati della società e i reietti, Gesù rispose: “Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento” (Luca 9:32).
Così è anche di me e di te. E’ il Maestro che è venuto a cercarci e ci ha chiamato, lì dove eravamo: seduti al tavolo delle imposte, seduti davanti al bancone di un bar mentre ammazzavamo il tempo bevendo e cercando di annegare le domande e le angosce in un buon litro di birra, vestiti di abiti eleganti mentre soddisfatti dei nostri conseguimenti sentivamo forte il vuoto che essi portavano, bagnati di pianto mentre i nostri fallimenti si facevano sempre più pesanti e insopportabili, tesi come corde di violino mentre cercavamo di ottenere il massimo dalla vita, pieni di domande mentre la realtà ci appariva difficile e complicata. Proprio lì Gesù ci notò e disse: “Seguimi”.
Così è anche di te e di me per ciò che concerne non solo l’inizio del cammino ma anche il suo proseguimento.
In questa chiamata c’è tanto.
C’è il Suo amore, il Suo perdono e la Sua grazia, perché seguire Gesù significa seguire i Suoi passi fino alla città di Gerusalemme, verso la quale Egli si pose risolutamente in cammino (cfr. Luca 9:51): sul monte del Calvario, appena fuori dalla città, Egli morì sulla croce per il nostro peccato.
C’è la speranza e la vita eterna che Egli offre perché seguire Gesù significa anche, seguire la corsa di Pietro e Giovanni verso il sepolcro e scoprire che il Principe di Vita non poteva essere trattenuto dalla morte : quella stessa vita è la vita che ha chiunque crede in Lui.
C’è sicurezza e forza quotidiana perché seguire Gesù significa salire sul monte insieme ai discepoli, qualche istante prima della Sua ascensione, per ricevere le Sue parole, il Suo incoraggiamento, la Sua pace. “Ogni potere mi è stato dato, andate e fate miei discepoli. Io sono con voi.”(Matteo 28:18-20).
C’è una qualità di vita traboccante, fresca e indomita, perché seguire Gesù significa seguire le orme che Lui ha lasciato e che scrive sui nostri cuori mediante lo Spirito Santo .
C’è un attesa fatta non di rassegnazione e fatalismo, ma di impegno, amore, costanza, e gioia, perché seguire Gesù in questo lungo cammino significa partire da un Gerusalemme per arrivare ad un'altra Gerusalemme, splendente, gloriosa e “celeste”, dove Lui mi attende e desidera.
Il cammino non è facile. Gesù non lo ha mai nascosto; più volte parlando ai Suoi discepoli di ogni epoca ha detto cosa implicasse questo: rinunciare a sé stessi, prendere la propria croce, seguirlo dovunque le sue orme portino. Ma il Maestro cammina al mio e al tuo fianco. Ed Egli, mentre camminiamo, dischiude sempre più il Suo cuore: questo cammino è un cammino di amore, perdono, grazia, speranza, vita eterna, forza quotidiana, gioia, condivisione. Questo cammino è un cammino che dà alla vita il suo vero significato. Questo cammino è quello al quale il Maestro chiama tutti gli uomini e le donne.
Lascia che la polvere del Maestro ti ricopra.
Segui le Sue orme.
Ascolta le Sue parole.
Parlagli.
Lascia che il Maestro ti guidi, passo dopo passo.
Del resto questo è l’unico sentiero che porta a Casa.
Blessings.
J.
Luca 5:27-32
“ […] un monumento dice soltanto “sono arrivato fin qua” mentre un’orma dice “ero qui quando sono ripartito” (W. Faulkner)
Levi sedeva al banco delle imposte come ogni giorno, esercitando la sua impopolare professione. Egli era un impiegato dell’ufficio delle imposte e dunque una persona la cui figura ricordava costantemente ai suoi connazionali come Israele fosse una nazione soggetta, politicamente, all’impero Romano. Non solo. Levi era una di quelle persone che la gente cercava con tutte le forze di evitare: il Talmud stesso definiva gli esattori di tasse, forse con qualche ragione, dei “rapinatori”.
Gesù era appena uscito dalla casa in cui aveva guarito un uomo paralitico e stava, probabilmente, uscendo dalla città quando incontrò Levi. Lo trovò mentre egli stava esercitando le sue contestate mansioni.
Gesù lo notò. Lo guardò e gli rivolse una semplice parola: “Seguimi”.
La risposta di Levi fu sorprendentemente rapida. Egli lasciata ogni cosa (un particolare che Luca sottolinea con gran vigore rispetto agli altri sinottici), si alzò in piedi e si mise a seguirlo.
Si mise a seguirlo.
Questa espressione così concisa è molto densa e ricca di implicazioni. Per Levi, significò perdere in maniera definitiva il proprio posto di lavoro. Una volta abbandonata quella postazione egli non poteva più tornare indietro: quel gesto era un biglietto di sola andata, un’azione definitiva. Egli lasciò dietro alle spalle le sue ricchezze. Solitamente infatti, gli esattori di tasse, per non parlare poi dei capi di distretto come Zaccheo, erano persone benestanti con un letto soffice sotto il quale stavano tante tintinnanti monete. Alzarsi e seguire Gesù implicava la rinuncia a tutto questo, che da qualche anno era stato il mondo del puntuale esattore di tasse.
Ciò che però colpisce ancora più con vigore in questo brano è il verbo che Luca usa per esprimere ciò che fece Levi. Si mise a seguirlo, cioè Levi cominciò quel giorno a seguire Gesù. Akolutheo è un verbo molto bello, usato primariamente nei Vangeli: riferito alle folle è usato in senso neutrale e non implica il formarsi di qualche convinzione. È forse il seguire delle folle e delle masse, fatto più di curiosità che di passione personale. Quando però è riferito a singoli individui esso prende il significato di “seguire in rapporto intimo”; esso sottolinea l’inizio di quel “cammino lungo e in una sola direzione” che è noto come l’essere discepoli.
Levi aveva appena mosso il primo passo su quella strada che può essere percorsa soltanto in avanti.
L’immagine che questo verbo e questa azione suggeriscono è di straordinaria potenza perché si inserisce nel contesto dell’epoca con una dimensione nuova e fresca. Nella cultura di quei tempi era pratica comune scegliere un rabbi che diventasse la propria guida. Scelto il rabbi, il discepolo aveva una sola occupazione: ricevere più nozioni e insegnamenti possibili dal proprio maestro. Questo aspetto era così sentito che il maestro era seguito dovunque: mentre camminava, mentre parlava con altri, mentre comprava la frutta e la verdura, mentre svolgeva le faccende domestiche e addirittura mentre andava in bagno! La paura era quella di perdere una eventuale “perla” di saggezza o di non imparare una nuova preghiera. Si narra nel Talmud di una caso estremo in cui un discepolo scivolò di soppiatto nel letto del proprio rabbi e si pose tra moglie e marito, sotto le coperte. Al rimprovero del maestro egli rispose “Anche questa è Torah e devo imparare”. A parte i casi estremi, si comprende l’importanza di questo atto di seguire il proprio rabbi da una benedizione che uno studioso di Antico Testamento, Ray van der Laan, ci riporta:
“possa tu esser sempre ricoperto dalla polvere del tuo maestro”.
Possa cioè la polvere dei piedi del tuo maestro, alzata dai suoi sandali, coprire le tue vesti e avvolgerti, perché ciò significa che lo stai seguendo mentre lui cammina, significa che i tuoi occhi sono puntati su di lui, che le tue orecchie sono protese e pronte ad ascoltare ogni sua parola.
Levi cominciò questo tipo di cammino.
Fu Gesù, il Maestro, che cercò Levi. Gesù affermò di esser venuto specificatamente e volontariamente a chiamare l’esattore di tasse. Infatti, ai farisei che come al solito erano scioccati e scandalizzati dal fatto che il Signore si associasse con gli emarginati della società e i reietti, Gesù rispose: “Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento” (Luca 9:32).
Così è anche di me e di te. E’ il Maestro che è venuto a cercarci e ci ha chiamato, lì dove eravamo: seduti al tavolo delle imposte, seduti davanti al bancone di un bar mentre ammazzavamo il tempo bevendo e cercando di annegare le domande e le angosce in un buon litro di birra, vestiti di abiti eleganti mentre soddisfatti dei nostri conseguimenti sentivamo forte il vuoto che essi portavano, bagnati di pianto mentre i nostri fallimenti si facevano sempre più pesanti e insopportabili, tesi come corde di violino mentre cercavamo di ottenere il massimo dalla vita, pieni di domande mentre la realtà ci appariva difficile e complicata. Proprio lì Gesù ci notò e disse: “Seguimi”.
Così è anche di te e di me per ciò che concerne non solo l’inizio del cammino ma anche il suo proseguimento.
In questa chiamata c’è tanto.
C’è il Suo amore, il Suo perdono e la Sua grazia, perché seguire Gesù significa seguire i Suoi passi fino alla città di Gerusalemme, verso la quale Egli si pose risolutamente in cammino (cfr. Luca 9:51): sul monte del Calvario, appena fuori dalla città, Egli morì sulla croce per il nostro peccato.
C’è la speranza e la vita eterna che Egli offre perché seguire Gesù significa anche, seguire la corsa di Pietro e Giovanni verso il sepolcro e scoprire che il Principe di Vita non poteva essere trattenuto dalla morte : quella stessa vita è la vita che ha chiunque crede in Lui.
C’è sicurezza e forza quotidiana perché seguire Gesù significa salire sul monte insieme ai discepoli, qualche istante prima della Sua ascensione, per ricevere le Sue parole, il Suo incoraggiamento, la Sua pace. “Ogni potere mi è stato dato, andate e fate miei discepoli. Io sono con voi.”(Matteo 28:18-20).
C’è una qualità di vita traboccante, fresca e indomita, perché seguire Gesù significa seguire le orme che Lui ha lasciato e che scrive sui nostri cuori mediante lo Spirito Santo .
C’è un attesa fatta non di rassegnazione e fatalismo, ma di impegno, amore, costanza, e gioia, perché seguire Gesù in questo lungo cammino significa partire da un Gerusalemme per arrivare ad un'altra Gerusalemme, splendente, gloriosa e “celeste”, dove Lui mi attende e desidera.
Il cammino non è facile. Gesù non lo ha mai nascosto; più volte parlando ai Suoi discepoli di ogni epoca ha detto cosa implicasse questo: rinunciare a sé stessi, prendere la propria croce, seguirlo dovunque le sue orme portino. Ma il Maestro cammina al mio e al tuo fianco. Ed Egli, mentre camminiamo, dischiude sempre più il Suo cuore: questo cammino è un cammino di amore, perdono, grazia, speranza, vita eterna, forza quotidiana, gioia, condivisione. Questo cammino è un cammino che dà alla vita il suo vero significato. Questo cammino è quello al quale il Maestro chiama tutti gli uomini e le donne.
Lascia che la polvere del Maestro ti ricopra.
Segui le Sue orme.
Ascolta le Sue parole.
Parlagli.
Lascia che il Maestro ti guidi, passo dopo passo.
Del resto questo è l’unico sentiero che porta a Casa.
mercoledì 24 settembre 2008
Dio veste mocassini - riflessioni mattutine durante una passeggiata
Un altro momento di epifania.
L'ho avuto proprio stamattina mentre camminavo per le vie della città, tra i banchi colorati del mercato e la folla di persone che guardava con interesse alle merci esposte: vestiti, pantaloni, cappotti, quadri, stoffe, tende.
Ho camminato per parecchio tempo, con i polmoni pieni non solo d'aria ma, per quanto strano possa essere, pieni pure di gratitudine (penso che questo sia il modo migliore per spiegare il piacevole solletico che accompagnava l'atto fisico di inspirare ed espirare).
Immerso in pensieri, ad un tratto si sono combinati nella mia testa due ricordi provenienti da due domini temporali differenti.
Il primo ricordo è sicuramente più anziano: aveva a che fare con una vecchio proverbio indiano (indiano d'america per intenderci) che avevo letto per caso su una pietra circa un anno fa, in uno di quei negozi in cui solitamente entri soltanto perchè qualche amica o parente (in questo caso mia sorella e una sua amica) decide di entrare a curiosare attratta dalle miriadi di ciappini e profumi. Esso dice più o meno così: "Prima di giudicare una qualsiasi persona cammina nei suoi mocassini almeno per tre lune".
Il secondo ricordo è freschissimo. Devo dire che più che un ricordo è un vero e proprio ritornello. Sto lavorando infatti sulla lettera agli Ebrei: sulla sua teologia, sulla sua forma, sulla sua storia, sulla sua lingua e soprattutto sul suo testo. Lo scritto è piuttosto un sermone (e non una epistola). Un sermone scritto da un pastore ai suoi amici i quali non se la stavano passando per niente bene (probabilmente una seconda persecuzione violenta dopo quella già subita sotto l'imperatore Claudio). Comunque non è del materiale introduttivo al testo che voglio parlare.
Voglio intonare piuttosto un'altra volta quel ritornello che "fischietto" sovente in questi giorni.
In uno dei capitoli che aprono il testo si trovano scritte le seguenti parole: "Poichè dunque i figli hanno in comune sangue e carne, Egli pure vi ha similmente partecipato [..]Perciò Egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa (grassetti miei)." (Ebrei 2:14, 17).
Camminando, cose a volte separate nella testa, si mischiano insieme e si fondono per dare origine a una visione nuova e fresca della realtà.
Camminare nei mocassini di un'altra persona significa immedesimarsi, senza recitare, in quello che l'altra persona sta passando o affrontando; significa andare oltre alle apparenze e comprendere invece quali sono le sue motivazioni; significa avere com-passione, cioè, nel senso vero e originale del termine, provare lo stesso pathos (sofferenze, gioie, ansie, paure, speranze, aspettative, gioie, ecc..). Camminare nei mocassini di una persona per almeno tre lune crea legami, dialogo, misericordia, senso di appartenenza alla comunità degli uomini e delle donne, allontana dall'individualismo e da forme di giudizio sterili, superficiali, scontate e fin troppo semplici da pronunciare. Camminare nei mocassini di una persona significa cambiare il punto di vista e significa guardarsi intorno con occhi per la prima volta rivolti al prossimo e non a me stesso (formidabile la metafora che i riformatori usavano dicendo che l'uomo "naturale" è "incurvato su sè stesso). Camminare nei mocassini di un altro vuol dire comprendere. Camminare nei mocassini di una persona significa tendere una mano, aiutare.
Se questo è già qualcosa di nuovo per persone che vivono in una società ego-centrica come la nostra, ancora più sorprendente è quello che il sermone noto come epistola agli Ebrei ci dice.
Gesù Cristo incarnandosi ha calzato i nostri mocassini.
Mi piace questa immagine. Si aggiunge a una serie di eventi biblici che hanno simile potenza immaginifica.
Dio si rotola e si azzuffa nel fango con Giacobbe; dialoga con Abraamo e Mosè come se fossero amici di vecchia data (per intenderci quelli che hanno giocato a nascondino nella stessa via durante l'infanzia, che sono stati compagni di banco per una vita e che ora guardano insieme la partita alla Tv); danza a tutta forza per un popolo, quello di Israele, che scopriamo essere fra le Sue gioie più grandi; si fregia dei Suoi amici e amiche che hanno percorso i sentieri di questo mondo al Suo fianco (vedi Ebrei 11 e in particolare il versetto 16)
e infine si scopre, come se non bastasse, che Egli ha calzato i nostri mocassini.
Eugene Peterson nel suo meraviglioso lavoro di traduzione della Bibbia (The Message) rende in questo modo significativo Ebrei 2:17: "That's why he had to enter into every detail of human life".
Io, che non sono tecnicamente un traduttore, mi spingo oltre e parafraso lo stesso versetto nel modo seguente:
"Perciò Egli doveva calzare i mocassini dei Suoi fratelli e sorelle".
Sono forse ripetitivo. Ma del resto quando si guarda a una immagine, non si esaurisce al primo colpo d'occhio quello che l'immagine stessa vuole comunicare. La potenza comunicativa insita nelle figure consiste, tra le altre cose, nella loro abilità di imprimersi sull'anima in maniera incisiva e profonda, permettendo poi una meditazione e riflessione continua, che si allarga in cerchi concentrici a partire dal nucleo semantico (cioè a partire dal concetto che si vuole trasmettere).
Mi piace davvero questa immagine.
Che sia seduto o in piedi, pronto a camminare, che stia dormendo o stia mangiando, che stia leggendo o guardando un panorama, che stia ridendo o stia piangendo, Gesù Cristo sa cosa provo perchè anche Lui ha camminato nelle mie scarpe.
Non solo. Nel camminare nelle mie scarpe Egli ha vissuto una qualità di vita diversa: bella, abbondante, pura, misericordiosa, fresca, buona, santa, piena di compassione, di bene verso gli altri, amorevole, di servizio, giusta, amabile. In poche parole, la vita così come originariamente Dio l'aveva intesa, prima che noi uomini ci mettessimo il proverbiale "zampino" cercando di vivere una vita al di fuori di un rapporto personale con Dio.
Guardando ai miei piedi realizzo che sono compreso e capito in maniera ancor più profonda di quanto io creda. Cristo ha messo i miei mocassini e ha simpatizzato (sym-pathos, vedi Ebrei 4:15)
Ho la possibilità di una vita diversa anche io, piena di quelle qualità di cui si parlava poco prima. Cristo ha messo i miei mocassini e nei miei mocassini ha vissuto "senza commettere peccato"(cfr. ancora Ebrei 4:15), cioè vincendo quel principio che agisce in noi e che ci "incurva su noi stessi"tenendoci lontani da Dio e separandoci dagli altri esseri umani.
Quando guardo ai miei piedi, so di non essere abbandonato a me stesso in questo cammino esaltante e arduo chiamato vita: il Dio che è talmente grande da far sembrare la Terra lo sgabello dei Suoi piedi, si è chinato e ha, in modo affascinante e per certi versi sfuggente alla compresione, camminato nelle mie scarpe e segnato con i Suoi passi una nuova via.
Egli è conosciuto come Emmanuele, che tradotto significa Dio con noi,
ovvero
il Dio che veste mocassini.
Guardando ai Suoi piedi, si può capire molto del Suo cuore: Egli ci ama e desidera stare con noi.
L'ho avuto proprio stamattina mentre camminavo per le vie della città, tra i banchi colorati del mercato e la folla di persone che guardava con interesse alle merci esposte: vestiti, pantaloni, cappotti, quadri, stoffe, tende.
Ho camminato per parecchio tempo, con i polmoni pieni non solo d'aria ma, per quanto strano possa essere, pieni pure di gratitudine (penso che questo sia il modo migliore per spiegare il piacevole solletico che accompagnava l'atto fisico di inspirare ed espirare).
Immerso in pensieri, ad un tratto si sono combinati nella mia testa due ricordi provenienti da due domini temporali differenti.
Il primo ricordo è sicuramente più anziano: aveva a che fare con una vecchio proverbio indiano (indiano d'america per intenderci) che avevo letto per caso su una pietra circa un anno fa, in uno di quei negozi in cui solitamente entri soltanto perchè qualche amica o parente (in questo caso mia sorella e una sua amica) decide di entrare a curiosare attratta dalle miriadi di ciappini e profumi. Esso dice più o meno così: "Prima di giudicare una qualsiasi persona cammina nei suoi mocassini almeno per tre lune".
Il secondo ricordo è freschissimo. Devo dire che più che un ricordo è un vero e proprio ritornello. Sto lavorando infatti sulla lettera agli Ebrei: sulla sua teologia, sulla sua forma, sulla sua storia, sulla sua lingua e soprattutto sul suo testo. Lo scritto è piuttosto un sermone (e non una epistola). Un sermone scritto da un pastore ai suoi amici i quali non se la stavano passando per niente bene (probabilmente una seconda persecuzione violenta dopo quella già subita sotto l'imperatore Claudio). Comunque non è del materiale introduttivo al testo che voglio parlare.
Voglio intonare piuttosto un'altra volta quel ritornello che "fischietto" sovente in questi giorni.
In uno dei capitoli che aprono il testo si trovano scritte le seguenti parole: "Poichè dunque i figli hanno in comune sangue e carne, Egli pure vi ha similmente partecipato [..]Perciò Egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa (grassetti miei)." (Ebrei 2:14, 17).
Camminando, cose a volte separate nella testa, si mischiano insieme e si fondono per dare origine a una visione nuova e fresca della realtà.
Camminare nei mocassini di un'altra persona significa immedesimarsi, senza recitare, in quello che l'altra persona sta passando o affrontando; significa andare oltre alle apparenze e comprendere invece quali sono le sue motivazioni; significa avere com-passione, cioè, nel senso vero e originale del termine, provare lo stesso pathos (sofferenze, gioie, ansie, paure, speranze, aspettative, gioie, ecc..). Camminare nei mocassini di una persona per almeno tre lune crea legami, dialogo, misericordia, senso di appartenenza alla comunità degli uomini e delle donne, allontana dall'individualismo e da forme di giudizio sterili, superficiali, scontate e fin troppo semplici da pronunciare. Camminare nei mocassini di una persona significa cambiare il punto di vista e significa guardarsi intorno con occhi per la prima volta rivolti al prossimo e non a me stesso (formidabile la metafora che i riformatori usavano dicendo che l'uomo "naturale" è "incurvato su sè stesso). Camminare nei mocassini di un altro vuol dire comprendere. Camminare nei mocassini di una persona significa tendere una mano, aiutare.
Se questo è già qualcosa di nuovo per persone che vivono in una società ego-centrica come la nostra, ancora più sorprendente è quello che il sermone noto come epistola agli Ebrei ci dice.
Gesù Cristo incarnandosi ha calzato i nostri mocassini.
Mi piace questa immagine. Si aggiunge a una serie di eventi biblici che hanno simile potenza immaginifica.
Dio si rotola e si azzuffa nel fango con Giacobbe; dialoga con Abraamo e Mosè come se fossero amici di vecchia data (per intenderci quelli che hanno giocato a nascondino nella stessa via durante l'infanzia, che sono stati compagni di banco per una vita e che ora guardano insieme la partita alla Tv); danza a tutta forza per un popolo, quello di Israele, che scopriamo essere fra le Sue gioie più grandi; si fregia dei Suoi amici e amiche che hanno percorso i sentieri di questo mondo al Suo fianco (vedi Ebrei 11 e in particolare il versetto 16)
e infine si scopre, come se non bastasse, che Egli ha calzato i nostri mocassini.
Eugene Peterson nel suo meraviglioso lavoro di traduzione della Bibbia (The Message) rende in questo modo significativo Ebrei 2:17: "That's why he had to enter into every detail of human life".
Io, che non sono tecnicamente un traduttore, mi spingo oltre e parafraso lo stesso versetto nel modo seguente:
"Perciò Egli doveva calzare i mocassini dei Suoi fratelli e sorelle".
Sono forse ripetitivo. Ma del resto quando si guarda a una immagine, non si esaurisce al primo colpo d'occhio quello che l'immagine stessa vuole comunicare. La potenza comunicativa insita nelle figure consiste, tra le altre cose, nella loro abilità di imprimersi sull'anima in maniera incisiva e profonda, permettendo poi una meditazione e riflessione continua, che si allarga in cerchi concentrici a partire dal nucleo semantico (cioè a partire dal concetto che si vuole trasmettere).
Mi piace davvero questa immagine.
Che sia seduto o in piedi, pronto a camminare, che stia dormendo o stia mangiando, che stia leggendo o guardando un panorama, che stia ridendo o stia piangendo, Gesù Cristo sa cosa provo perchè anche Lui ha camminato nelle mie scarpe.
Non solo. Nel camminare nelle mie scarpe Egli ha vissuto una qualità di vita diversa: bella, abbondante, pura, misericordiosa, fresca, buona, santa, piena di compassione, di bene verso gli altri, amorevole, di servizio, giusta, amabile. In poche parole, la vita così come originariamente Dio l'aveva intesa, prima che noi uomini ci mettessimo il proverbiale "zampino" cercando di vivere una vita al di fuori di un rapporto personale con Dio.
Guardando ai miei piedi realizzo che sono compreso e capito in maniera ancor più profonda di quanto io creda. Cristo ha messo i miei mocassini e ha simpatizzato (sym-pathos, vedi Ebrei 4:15)
Ho la possibilità di una vita diversa anche io, piena di quelle qualità di cui si parlava poco prima. Cristo ha messo i miei mocassini e nei miei mocassini ha vissuto "senza commettere peccato"(cfr. ancora Ebrei 4:15), cioè vincendo quel principio che agisce in noi e che ci "incurva su noi stessi"tenendoci lontani da Dio e separandoci dagli altri esseri umani.
Quando guardo ai miei piedi, so di non essere abbandonato a me stesso in questo cammino esaltante e arduo chiamato vita: il Dio che è talmente grande da far sembrare la Terra lo sgabello dei Suoi piedi, si è chinato e ha, in modo affascinante e per certi versi sfuggente alla compresione, camminato nelle mie scarpe e segnato con i Suoi passi una nuova via.
Egli è conosciuto come Emmanuele, che tradotto significa Dio con noi,
ovvero
il Dio che veste mocassini.
Guardando ai Suoi piedi, si può capire molto del Suo cuore: Egli ci ama e desidera stare con noi.
mercoledì 27 agosto 2008
E-mail, fantasmi del passato, la famiglia, un amico e l'amore di Dio
Davide l'Antropologo non è il nome di un personaggio da me inventato (così' come sono solito fare nel mio cogitare notturno circa i possibili protagonisti del romanzo che prima o poi scriverò), ma grazie a Dio (nel pieno senso di questa espressione) è una persona esistente che posso vantare di chiamare amico e fratello (anche in questo caso nel pieno senso dei termini).
Io sto attraversando, lo ammetto, un periodo alquanto strano: ci sono "fantasmi del passato" che ancora mi perseguitano e io, fin da bambino, ho sempre avuto una paura matta degli ectoplasmi, sia quelli di livello proletario (la classica coperta bianca con due buchi per gli occhi e l'esclamazione "uhhh, uhhhhhh") sia quelli di livello 4 (per intenderci le entità che fanno la loro comparsa nel grandissimo american movie dell'84 "Ghostbusters"). Purtroppo non ho a disposizione accelleratori protonici per irradiare queste noiose ombre danzerine; tra le altre cose ho scoperto recentemente, dopo lunghi e talvolta estenuanti tentativi, che i fantasmi con cui ho a che fare resistono a diverse forme di armi che la pratica popolare aveva decretato veri e propri toccasana e antidoti: uscire tutte le sere per una birretta in compagnia o per strafogarsi di gelato, gettarsi anima e corpo in qualche attività "placebica" (leggere come un matto, passeggiare freneticamente per chilometri, cercare di prendere le cose superficialmente indossando maschere e facendo "quello che se ne frega", ecc..), riversare la rabbia su chi sta intorno, isolarsi in una specie di titanico disdegno verso il mondo, comprare compulsivamente oggetti (nel mio caso libri o dischi) che per qualche istante diano la felicità dell'acquisto e del possedere qualcosa di desiderato, ecc. Dunque questi rimedi "naturali" sono falliti.
E così ecco che questo senso di rabbia e impotenza, questa voglia di usare la lingua come una spada tagliente per rendere le ferite ricevute, questa volontà di deridere chi mi ha fatto star male, questa invidia (perchè sembra davvero che poi, chi fa star male, sia capace di "rifarsi una vita"), questo desiderio di "soddisfazione" nel senso cavalleresco del termine (ovvero vendetta), questo egoismo strutturale che mi fa pensare che i miei problemi, il mio soffrire, la mia incapacità di fidarmi di nuovo, il mio modo distorto di vedere me stesso e gli altri, siano il centro del mondo (la cosidetta teoria "jonathancentrica") ecco, dicevo, che tutto ciò (e questa potrebbe essere la punta dell'ice-berg) infesta la mia cameretta più segreta, dove alle pareti ci sono scaffali non pieni di libri ma di ricordi, affetti, visi, sentimenti e desideri.
Davide l'Antropologo, non so come, l'altro giorno deve aver intuito qualcosa (non lo dubitavo; è un lettore acutissimo e tra le righe di questo blog-flusso-di-coscienza deve aver compreso il "tra le righe" che le parole non esprimevano esplicitamente ma suggerivano con gli spazi bianchi e le frasi non scritte); così mi ha scritto una e-mail dove mi chiedeva come me la passavo.
Ho risposto.
Ovviamente a mio modo: quindi l'ho sommerso con righe e righe di pensieri, riflessioni e confessioni.
Anche Davide l'Antropologo ha risposto.
L'e-mail l'ho stampata e l'ho incorniciata (forse incorniciata no, ma è nella mia Bibbia inglese da buon vecchio reverendo - forse adesso mi dò questo titolo per scherzo ma avverto tutti i lettori che il mio sogno segreto è di diventare un giorno un "reverendo"a tutti gli effetti). La lettera elettronica conteneva in particolare una frase che si va ad aggiungere a una serie di altre frasi che, uno alla volta, i componenti della mia famiglia mi hanno rivolto, vedendo per l'appunto la mia cameretta ancora infestata dagli ectoplasmi di cui parlavo prima.
La riporto.
TUTTA LA VITA è questo..portare a Dio cose storte, e lui riesce a farci cose buone
Epifania!
Ho avuto momenti epici dopo aver letto queste parole. Mi sono tornate in mente un sacco di cose, tra cui la traduzione di un Salmo fatta da Eugene Peterson (nel suo meraviglioso lavoro in The Message) che dice qualcosa di simile. Non la ricordo alla lettera ma il senso era " Tu vedi, o Dio, i pezzi sparsi della mia vita; ma Tu mi ricomponi" (non mi darò pace finchè non ritrovo il taccuino o il foglio o la tavoletta di creta su cui l'avevo segnata). Non solo. Mi è venuto in mente anche quanto ho letto proprio ieri su un libro di Donald Miller (Blue Like Jazz - non religious thoughts on Christian Spirituality) e Davide L'Antropologo mi ha offerto la miglior traduzione in italiano che ci potesse essere; Don Miller dice infatti che la più grande potenzialità insita nel Cristianesimo è da trovarsi nella parola "repentance" - "the power of Christian spiritualty has always rested in repentance". Davide mi ha detto la stessa cosa con termini diversi. Leggere queste parole in un libro già fa effetto (io sono rimasto di stucco); sentirsele dire da una persona interessata alla tua vita è una esperienza ancor più vivida.
Mi spiego meglio circa la "repentance".
Quando mi rendo conto, come io mi sto rendendo conto attraverso le parole che sia la mia famiglia sia i miei amici mi rivolgono, del fatto che qualcosa non sta funzionando nel modo giusto e c'è da qualche parte un vaso rotto, l'unica cosa che posso fare per cambiare la situazione, è portare direttamente tutti questi pezzi a Dio confessando appunto la situazione in cui mi trovo: Lui ama ricomporre le vite sparpagliate in vasi interi. E non si stanca nemmeno quando, spesse volte, come accade nella quotidianità, il nostro vaso si rompe più e più volte.
Quello che ho imparato dalle parole di Davide è di lasciarmi amare, di perdonare, di sperimentare la riconciliazione con il genere umano e con me stesso; quello che ho ricevuto dalle sue parole è una lezione importante: vivere davanti a Dio non come un estraneo in casa, ma come un figlio, vicino al cuore del Papà.
Ecco quello che ho scritto nel mio taccuino in questi giorni (prima della sua e-mail e dopo la sua e-mail - e non penso sia ancora una versione definitiva di questi pensieri, diciamo che è solo un incipit):
"Ampliare il concetto di accettazione nell'amore. Tu pensi, erratamente, che per essere amato devi prima di tutto offrire e mostrare, far vedere chi sei; in definitiva far sfoggio delle piume come un peacock. Così sei condotto a non essere te stesso; fingi pretending to be waht you are not. Ricordi la frase di Hawthorne nella Lettera Scarlatta? Se fingi di essere una cosa con gli altri e sei te stesso solo quando sei solo, nella tua intimità, prima o poi corri il serio rischio di non sapere più distinguere tra il tuo viso e la maschera che indossi.
Devi imparare a fidarti nuovamente, a lasciare questi schemi mentali che prendono il loro spunto più dal commercio che dal relazionarsi correttamente e devi, soprattutto, imparare ad accettarti, accettare ed essere accettato. Stamattina hai avuto un ulteriore glimpse di ciò. Sei accettato così come sei. Dio non ti ama per quello che gli puoi offrire, per ciò che puoi produrre, non ti ama per i doni che hai o per le tue abilità, nè per i tuoi capelli, le tue orecchie, le tue mani e i tuoi piedi; Dio ti ama prima di tutto perchè sei, esisti, proprio così come Lui stesso ti ha fatto. Sei voluto da Lui, sei cercato, sei un figlio per Lui e per un padre il figlio è l'amato. Egli ama le tue particolarità; quelli che tu chiami in alcuni momenti pregi e in altri momenti difetti (le cose che lei non accettava o che gli altri non accettano o capiscono di te). Sei amato in quanto Jonathan, non in quanto Jonathan "il sognatore", Jonathan "lo scrittore", Jonathan "l'entusiasta", Jonathan "quello che mi fa comodo perchè è disponibile", Jonathan "la peste", Jonathan "il biondo" o Jonathan "quello che gli altri dicono lui sia", cioè tutti i soprannomi e i modi di vederti che gli altri hanno di te, caricati dalle loro aspettative. Sei amato dunque così come sei. Sei amato trinitariamente da Padre, Figlio e Spirito Santo; sei voluto , desiderato, accettato e invitato a prendere parte alla comunione intra-trinitaria. Ciò dovrebbe anche spingerti a rivedere il tuo modo di rapportarti alla gente e a chi ti sta intorno. Basta con metafore commerciali e con il tuo essere cavaliere solitario solo per vendicarti del fatto di non sentire completa accettazione da parte degli altri. Basta vivere con i confronti a cui lei ti aveva iniziato e di cui sei ancora vittima. Basta anche con il vittimismo, perchè quello che è stato è passato; ora hai davanti nuove prospettive, puoi rialzarti, puoi ricomporre il puzzle. Non tutte le persone sono uguali, non tutte ti vedono per quello che puoi dare; c'è chi ti ama per come sei e soffre a vederti in questo stato ferino (sembri per davvero un lupo ferito). Sii te stesso. Vivi nella dimensione dell'amore incondizionato. Accettati, accetta gli altri e lasciati accettare. Accetta il Primo Amore e lascia che la Sua dimensione rivoluzioni il tuo universo: non più jonathancentrico, ma Trinitocentrico o Cristocentrico. Solo così sarai in grado di vivere non incurvato su te stesso ma proteso verso il prossimo, colui che ti sta vicino, che ha bisogno di amore o desidera amarti."
Davide l'Antropologo è un fratello e un amico. Si scherza e si ride; si beve una birra da qualche parte per l'Italia (l'ultima a Nocera Umbra) e si parla di lavoro con la casa editrice e di come riuscire a portare ad altri questo messaggio di amore incondizionato da parte di Dio, messaggio che un giorno, per strade personalissime, ha toccato le nostre vite. Davide l'Antropologo però mi ha ricordato non solo questi momenti aurei che fanno parte dei ricordi che uno si tiene stretti, ma anche come questo messaggio deve essere il centro di gravità attorno al quale i nostri pianeti ruotano armonicamente e come questa rivoluzione "copernicana" possa influenzare le nostre vite trasformandole da pozzi a sorgenti.
Grazie. Forse un termine troppo semplice e "secco", ma detto in modo profondo e sincero. Sì, grazie.
E tutto quello che ho scritto dimostra come isolandomi rischio di perdere la benedizione che proviene non dal vivere in società (secondo le regole della mutua sopportazione imposte dalla legge o da una qualche forma di regolamento della serie "vivi e lascia vivere") ma dal vivere in comunità (dove la parola d'ordine è koinonia) quella stessa comunità dove vi sono caratteri diversi ma un medesimo modo di sentire, dove vi è idiosincrasia ma al contempo mutua compenetrazione d'animo, dove vi è personalità ma non individualismo, dove vi è particolarità vissuta nella reciprocità, dove c'è l'io e il tu (in mutua relazione), dove c'è amore che dona e accetta sapendo che, come sono solito ripetere citando John Donne, nessuno è nato per essere un'isola.
Io sto attraversando, lo ammetto, un periodo alquanto strano: ci sono "fantasmi del passato" che ancora mi perseguitano e io, fin da bambino, ho sempre avuto una paura matta degli ectoplasmi, sia quelli di livello proletario (la classica coperta bianca con due buchi per gli occhi e l'esclamazione "uhhh, uhhhhhh") sia quelli di livello 4 (per intenderci le entità che fanno la loro comparsa nel grandissimo american movie dell'84 "Ghostbusters"). Purtroppo non ho a disposizione accelleratori protonici per irradiare queste noiose ombre danzerine; tra le altre cose ho scoperto recentemente, dopo lunghi e talvolta estenuanti tentativi, che i fantasmi con cui ho a che fare resistono a diverse forme di armi che la pratica popolare aveva decretato veri e propri toccasana e antidoti: uscire tutte le sere per una birretta in compagnia o per strafogarsi di gelato, gettarsi anima e corpo in qualche attività "placebica" (leggere come un matto, passeggiare freneticamente per chilometri, cercare di prendere le cose superficialmente indossando maschere e facendo "quello che se ne frega", ecc..), riversare la rabbia su chi sta intorno, isolarsi in una specie di titanico disdegno verso il mondo, comprare compulsivamente oggetti (nel mio caso libri o dischi) che per qualche istante diano la felicità dell'acquisto e del possedere qualcosa di desiderato, ecc. Dunque questi rimedi "naturali" sono falliti.
E così ecco che questo senso di rabbia e impotenza, questa voglia di usare la lingua come una spada tagliente per rendere le ferite ricevute, questa volontà di deridere chi mi ha fatto star male, questa invidia (perchè sembra davvero che poi, chi fa star male, sia capace di "rifarsi una vita"), questo desiderio di "soddisfazione" nel senso cavalleresco del termine (ovvero vendetta), questo egoismo strutturale che mi fa pensare che i miei problemi, il mio soffrire, la mia incapacità di fidarmi di nuovo, il mio modo distorto di vedere me stesso e gli altri, siano il centro del mondo (la cosidetta teoria "jonathancentrica") ecco, dicevo, che tutto ciò (e questa potrebbe essere la punta dell'ice-berg) infesta la mia cameretta più segreta, dove alle pareti ci sono scaffali non pieni di libri ma di ricordi, affetti, visi, sentimenti e desideri.
Davide l'Antropologo, non so come, l'altro giorno deve aver intuito qualcosa (non lo dubitavo; è un lettore acutissimo e tra le righe di questo blog-flusso-di-coscienza deve aver compreso il "tra le righe" che le parole non esprimevano esplicitamente ma suggerivano con gli spazi bianchi e le frasi non scritte); così mi ha scritto una e-mail dove mi chiedeva come me la passavo.
Ho risposto.
Ovviamente a mio modo: quindi l'ho sommerso con righe e righe di pensieri, riflessioni e confessioni.
Anche Davide l'Antropologo ha risposto.
L'e-mail l'ho stampata e l'ho incorniciata (forse incorniciata no, ma è nella mia Bibbia inglese da buon vecchio reverendo - forse adesso mi dò questo titolo per scherzo ma avverto tutti i lettori che il mio sogno segreto è di diventare un giorno un "reverendo"a tutti gli effetti). La lettera elettronica conteneva in particolare una frase che si va ad aggiungere a una serie di altre frasi che, uno alla volta, i componenti della mia famiglia mi hanno rivolto, vedendo per l'appunto la mia cameretta ancora infestata dagli ectoplasmi di cui parlavo prima.
La riporto.
TUTTA LA VITA è questo..portare a Dio cose storte, e lui riesce a farci cose buone
Epifania!
Ho avuto momenti epici dopo aver letto queste parole. Mi sono tornate in mente un sacco di cose, tra cui la traduzione di un Salmo fatta da Eugene Peterson (nel suo meraviglioso lavoro in The Message) che dice qualcosa di simile. Non la ricordo alla lettera ma il senso era " Tu vedi, o Dio, i pezzi sparsi della mia vita; ma Tu mi ricomponi" (non mi darò pace finchè non ritrovo il taccuino o il foglio o la tavoletta di creta su cui l'avevo segnata). Non solo. Mi è venuto in mente anche quanto ho letto proprio ieri su un libro di Donald Miller (Blue Like Jazz - non religious thoughts on Christian Spirituality) e Davide L'Antropologo mi ha offerto la miglior traduzione in italiano che ci potesse essere; Don Miller dice infatti che la più grande potenzialità insita nel Cristianesimo è da trovarsi nella parola "repentance" - "the power of Christian spiritualty has always rested in repentance". Davide mi ha detto la stessa cosa con termini diversi. Leggere queste parole in un libro già fa effetto (io sono rimasto di stucco); sentirsele dire da una persona interessata alla tua vita è una esperienza ancor più vivida.
Mi spiego meglio circa la "repentance".
Quando mi rendo conto, come io mi sto rendendo conto attraverso le parole che sia la mia famiglia sia i miei amici mi rivolgono, del fatto che qualcosa non sta funzionando nel modo giusto e c'è da qualche parte un vaso rotto, l'unica cosa che posso fare per cambiare la situazione, è portare direttamente tutti questi pezzi a Dio confessando appunto la situazione in cui mi trovo: Lui ama ricomporre le vite sparpagliate in vasi interi. E non si stanca nemmeno quando, spesse volte, come accade nella quotidianità, il nostro vaso si rompe più e più volte.
Quello che ho imparato dalle parole di Davide è di lasciarmi amare, di perdonare, di sperimentare la riconciliazione con il genere umano e con me stesso; quello che ho ricevuto dalle sue parole è una lezione importante: vivere davanti a Dio non come un estraneo in casa, ma come un figlio, vicino al cuore del Papà.
Ecco quello che ho scritto nel mio taccuino in questi giorni (prima della sua e-mail e dopo la sua e-mail - e non penso sia ancora una versione definitiva di questi pensieri, diciamo che è solo un incipit):
"Ampliare il concetto di accettazione nell'amore. Tu pensi, erratamente, che per essere amato devi prima di tutto offrire e mostrare, far vedere chi sei; in definitiva far sfoggio delle piume come un peacock. Così sei condotto a non essere te stesso; fingi pretending to be waht you are not. Ricordi la frase di Hawthorne nella Lettera Scarlatta? Se fingi di essere una cosa con gli altri e sei te stesso solo quando sei solo, nella tua intimità, prima o poi corri il serio rischio di non sapere più distinguere tra il tuo viso e la maschera che indossi.
Devi imparare a fidarti nuovamente, a lasciare questi schemi mentali che prendono il loro spunto più dal commercio che dal relazionarsi correttamente e devi, soprattutto, imparare ad accettarti, accettare ed essere accettato. Stamattina hai avuto un ulteriore glimpse di ciò. Sei accettato così come sei. Dio non ti ama per quello che gli puoi offrire, per ciò che puoi produrre, non ti ama per i doni che hai o per le tue abilità, nè per i tuoi capelli, le tue orecchie, le tue mani e i tuoi piedi; Dio ti ama prima di tutto perchè sei, esisti, proprio così come Lui stesso ti ha fatto. Sei voluto da Lui, sei cercato, sei un figlio per Lui e per un padre il figlio è l'amato. Egli ama le tue particolarità; quelli che tu chiami in alcuni momenti pregi e in altri momenti difetti (le cose che lei non accettava o che gli altri non accettano o capiscono di te). Sei amato in quanto Jonathan, non in quanto Jonathan "il sognatore", Jonathan "lo scrittore", Jonathan "l'entusiasta", Jonathan "quello che mi fa comodo perchè è disponibile", Jonathan "la peste", Jonathan "il biondo" o Jonathan "quello che gli altri dicono lui sia", cioè tutti i soprannomi e i modi di vederti che gli altri hanno di te, caricati dalle loro aspettative. Sei amato dunque così come sei. Sei amato trinitariamente da Padre, Figlio e Spirito Santo; sei voluto , desiderato, accettato e invitato a prendere parte alla comunione intra-trinitaria. Ciò dovrebbe anche spingerti a rivedere il tuo modo di rapportarti alla gente e a chi ti sta intorno. Basta con metafore commerciali e con il tuo essere cavaliere solitario solo per vendicarti del fatto di non sentire completa accettazione da parte degli altri. Basta vivere con i confronti a cui lei ti aveva iniziato e di cui sei ancora vittima. Basta anche con il vittimismo, perchè quello che è stato è passato; ora hai davanti nuove prospettive, puoi rialzarti, puoi ricomporre il puzzle. Non tutte le persone sono uguali, non tutte ti vedono per quello che puoi dare; c'è chi ti ama per come sei e soffre a vederti in questo stato ferino (sembri per davvero un lupo ferito). Sii te stesso. Vivi nella dimensione dell'amore incondizionato. Accettati, accetta gli altri e lasciati accettare. Accetta il Primo Amore e lascia che la Sua dimensione rivoluzioni il tuo universo: non più jonathancentrico, ma Trinitocentrico o Cristocentrico. Solo così sarai in grado di vivere non incurvato su te stesso ma proteso verso il prossimo, colui che ti sta vicino, che ha bisogno di amore o desidera amarti."
Davide l'Antropologo è un fratello e un amico. Si scherza e si ride; si beve una birra da qualche parte per l'Italia (l'ultima a Nocera Umbra) e si parla di lavoro con la casa editrice e di come riuscire a portare ad altri questo messaggio di amore incondizionato da parte di Dio, messaggio che un giorno, per strade personalissime, ha toccato le nostre vite. Davide l'Antropologo però mi ha ricordato non solo questi momenti aurei che fanno parte dei ricordi che uno si tiene stretti, ma anche come questo messaggio deve essere il centro di gravità attorno al quale i nostri pianeti ruotano armonicamente e come questa rivoluzione "copernicana" possa influenzare le nostre vite trasformandole da pozzi a sorgenti.
Grazie. Forse un termine troppo semplice e "secco", ma detto in modo profondo e sincero. Sì, grazie.
E tutto quello che ho scritto dimostra come isolandomi rischio di perdere la benedizione che proviene non dal vivere in società (secondo le regole della mutua sopportazione imposte dalla legge o da una qualche forma di regolamento della serie "vivi e lascia vivere") ma dal vivere in comunità (dove la parola d'ordine è koinonia) quella stessa comunità dove vi sono caratteri diversi ma un medesimo modo di sentire, dove vi è idiosincrasia ma al contempo mutua compenetrazione d'animo, dove vi è personalità ma non individualismo, dove vi è particolarità vissuta nella reciprocità, dove c'è l'io e il tu (in mutua relazione), dove c'è amore che dona e accetta sapendo che, come sono solito ripetere citando John Donne, nessuno è nato per essere un'isola.
Iscriviti a:
Post (Atom)